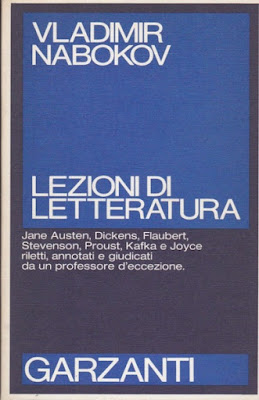Cosa
resta a un artista quando rifiuta una storia e la vede solo come un “asilo
per le nullità”, la giustificazione per ogni porcheria, il serbatoio di miti
perlopiù decorativi e ormai inutili, nonché il supporto del culto borghese della
memoria? Gli resta la propria persona, con la quale non riesce però a convivere
e a identificarsi, un passato da respingere esercitando la perdita attiva della
memoria, un presente banalizzato e inabitabile, e in definitiva il puro e
semplice “peso del mondo”; cioè, forse, un’altra storia che, “attraverso i
secoli, seminascosta da quella ufficiale e minacciosa, si è svolta come storia
delle passioni (della) gente, nella morte, nell’immeschinimento, la vera
storia”, che diventa allora la sua, il suo lavoro, che si tratta dunque di
perseguire. Ma non è così semplice quando le parole, il solo luogo per uno
scrittore dove cogliere quest’altra storia, anziché facilitarlo diventano la
prima difficoltà, in quanto si frappongono tra l’individuo e la realtà offuscandola
e falsificandola in ogni direzione, da quella letteraria che ha saturato il
mondo con un senso tutto fagocitato dalla storia rifiutata, a quella quotidiana
fatta soprattutto di formule e standard che predeterminano anche la più piccola
esperienza personale incanalandola verso generalizzazioni anonime e riciclate
su modelli passati, quasi ostruendo ogni possibilità di vita.
Certo, si
può vivere di questa impossibilità e costruire tutta un’opera sull’assoluta
negazione, e non è mancato chi lo ha tentato, salvo spesso finire nella
ripetizione o, più coerentemente, nel silenzio; si può fare un’arte di puro
gioco o basata su un linguaggio totalmente autocostruito, nel quale però “il
contenuto viene consumato, piuttosto che messo in evidenza”; si può fondare il
proprio lavoro sulla provocazione, sul sarcasmo e la dissacrazione; oppure
infine si può cercare di scoprire, ammesso che ce ne siano, “i luoghi non
ancora occupati dal senso”.
Peter
Handke ha percorso la terza strada nei suoi primi lavori, specie teatrali, che
lo hanno portato, oltre che alla collaborazione tuttora perdurante con alcuni
dei più importanti registi del nuovo cinema tedesco (Wenders e Herzog per
esempio), alla notorietà ancora giovanissimo in Austria, dove è nato nel 1942,
e in Germania poi, e in molti altri paesi, l’Italia tra i primi, dove è stato
subito tradotto; e prosegue nella quarta (conseguentemente, se non voleva
ricadere nelle prime due) nella fase più recente del suo lavoro, della quale
sono già noti anche al nostro pubblico gli ottimi risultati di Infelicità senza desideri e di La donna mancina, cui si aggiungono ora
il diario Il peso del mondo, scritto
tra il 1975 e il 1977, che ha offerto lo spunto per la considerazioni iniziali,
e il romanzo L’ora del vero sentire,
immediatamente precedente come data di pubblicazione ma perfettamente sintonico
nel discorso.
Gregor
Keuschnig, il protagonista di quest’ultimo, è un nipote eterodosso di Kafka,
come si deduce tanto dal nome e dall’iniziale del cognome, quanto dal fatto che
esca trasformato da un sogno nel quale si scopre omicida a sfondo sessuale.
Solo che qui la trasformazione, a differenza di La metamorfosi, non riguarda il suo corpo, bensì il suo rapporto
con la realtà esterna. Dopo quel sogno, che Keuschnig esperisce come qualcosa
di vitale, vero e reale, ogni sicurezza nella concretezza quotidiana va
perduta, ed egli “non si sente più a posto, ma non riesce a immaginare un altro
posto dove potrebbe sentirsi a suo agio; non può immaginare di continuare a
vivere come ha fatto finora, ma neanche di vivere come vive o ha vissuto
chiunque altro”. E tuttavia, mentre gli appaiono estranei e insignificanti il
suo lavoro di addetto stampa all’ambasciata austriaca di Parigi, la moglie e la
figlioletta e persino l’amante, e giunge a rifiutare ciò stesso che pensa e
sente nel suo legame con la memoria e il passato, contemporaneamente comincia
ad aprirglisi, violento, doloroso e sconcertante, come l’eventualità di uno
spiraglio rivelatore al quale però non sa come accostarsi, lo spazio della quotidianità.
Dal momento che ogni cosa, divenuta assurda, ha ormai perso il “suo”
significato, quello determinato dal normale sistema di valori e relazioni, ,
essa appare “strana”, disponibile per un senso diverso che risiede soltanto
nella sua intimità specifica. Ma Keuschnig questo ancora non lo sa: in preda a
una tensione totale e allucinata dei sensi, non fa che osservare anche il
minimo evento nel desiderio di cogliere l’assoluto nel momento stesso in cui lo
vive e nella singolarità di ciò che sta vivendo.
E
finalmente ha l’esperienza che cercava: tre semplici oggetti che scopre ai suoi
piedi nella sabbia, una foglia di ippocastano, il frammento di uno specchietto
e un fermaglio da capelli, gli rivelano che non c’è alcun “mistero
dell’Universo” da scoprire e di cui avere paura. Scopre che non c’è “alcun
mistero personale” per lui, “bensì l’IDEA di un mistero che esiste per tutti!”.
L’angoscia non scompare subito per sempre, naturale: deve prima allontanarsi da
tutto il precedente sistema di relazioni e affetti, non senza contraddizioni e
dolore; deve letteralmente spogliarsi dei vecchi abiti, ma ora, nel distacco,
le cose gli vengono generosamente in aiuto e può finalmente “inventarsi una
nuova personalità”. Comincia quindi a “osservare pazientemente gli altri”,
perché, se “con riluttanza aveva cominciato a percepire”, ora sono “tante le
storie che premono su di lui”. “Sto cambiando, in questo momento!”. si accorge,
giacché ora, anche se vede “le stesse cose di prima, dallo stesso angolo di
visuale, tuttavia sono diventate strane, e quindi esperibili”.
E’
evidente però che, se questa rivelazione nel
romanzo resta limitata al solo protagonista come un fatto personale e forse non
comunicabile, la possibilità della sua comunicazione si trasferisce nella
scrittura del romanzo, nell’estrema
tensione, corrispettiva di quella percettiva di Keuschnig, del suo linguaggio
che è desunto sì da quello di ogni giorno, ma viene come salvato dalla sua
banalità mediante un’assoluta laconicità e concretezza. In Il peso del mondo Handke dice: “il linguaggio d’ogni giorno, ch’è
stato finora il mio materiale di lavoro, mi appare nel frattempo così
esattamente vero da rendere impossibile ogni metamorfosi delle persone che esso
sorprende”, e auspica, pur prospettandosene tutte le difficoltà, “un altro
linguaggio di tutti i giorni, che si modifichi al posto di questo linguaggio
unico, vero” e sia “sempre nuovo”. Anche a benefico contraltare della
riluttanza cronica della nostra letteratura verso il linguaggio quotidiano,
possiamo leggere i romanzi di Handke come un tentativo di risposta a questa
sfida.
11-7-1981